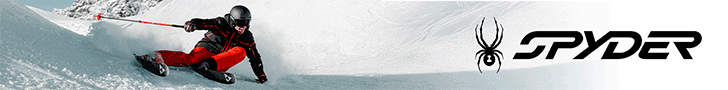Conversazioni con: Luca Calvi e Vinicio Stefanello
Wielick, Kammerlander e Moro sono fra gli alpinisti che hanno scritto la storia della disciplina sulle montagne più alte del pianeta. Chi lo ha fatto in solitaria, chi inverno o con un record di velocità, chi addirittura le ha scese con gli sci. DF Sport Specialist li ha invitati tutti e tre per una grande serata di “A tu per tu con i grandi dello sport”, un evento indimenticabile, durante il quale Luca Calvi e Vinicio Stefanello hanno conversato con loro rispolverando aneddoti tragici e divertenti, come solo la montagna sa fare vivere.
4Outdoor è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati.
Krzysztof Wielick
Come mai i polacchi sono diventati i Polacchi?
Non lo so sai, probabilmente perché ci siamo persi il principio della storia dell’alpinismo d’alta quota, dagli anni ’50 al ’64, e quando ce ne siamo resi conto, negli anni ’70 abbiamo dovuto cercare qualcosa di originale, qualcosa che nessuno aveva ancora fatto: le invernali.
Il nostro Club Alpino recuperò i permessi per una spedizione in Himalaya e a quel punto puntammo alla montagna più alta: l’Everest.
Gli altri membri della squadra avevano già un’esperienza decennale di alpinismo in alta montagna, io non ne avevo affatto, ma eravamo una squadra, non importava chi sarebbe arrivato in vetta, la squadra lavorava a quell’obiettivo.
Avevamo il permesso valido fino a 17 febbraio e raggiungemmo la vetta proprio quel giorno. Fu una gioia per tutti noi e per l’intera Polonia. Ancora oggi non si dice che fu una conquista di KrzysztofWielick e Leszek Cichy, fu una conquista dei Polacchi, il primo ottomila, e il più alto, scalato in inverno.
Caduto questo tabou, nei successivi sei anni i Team Polacchi scalarono altri sei 8.000 m in inverno. Per questo ci definirtono gli Ice Warriors (i guerrieri di ghiaccio).

Krzysztof, tu non sei famoso solo per le invernali ma anche perché ad un certo punto della carriera hai iniziato a compiere delle solitarie, parlaci di questo aspetto del tuo modo di fare alpinismo.
Beh in realtà non sono mai partito da casa lasciano i miei amici alpinisti, siamo sempre partiti in gruppo. Il punto è che a volte, nel corso di una spedizione mi trovavo in ottime condizioni fisiche e non avendo impegni con il gruppo mi veniva naturale partire da solo per la vetta. Così è successo al Brad Peak nel 1984, quando in 22 ore completai salita e discesa in solitaria, o nel 1990 quando aprii una nuova via dul Dhaulagiri in 16 ore dal campo base fino alla vetta, o ancora sullo Shisha Pangma, sempre una nuova via lungo la parete sud.
In molti mi hanno chiesto perché ho fatto tutto questo e la risposta che mi sono dato è che avevo molta fame di emozioni. Avevo bisogno di adrenalina.
C’è una spedizione o una vetta che ritieni fondamentale per la tua carriera?
Quella al Nanga Parbat, il mio 14° ottomila.
Già, ma prima di scalarlo andasti ad acclimatarti sul k2, spigolo Nord, con Christian Kuntner e Marco Bianchi, via dei Giapponesi!
Si, devo specificare che non era nei miei programmi di completare la corona dell’Himalaya, quello era stato un obiettivo di Reinhold Messner e Jerzy Kukuczka, ma ad un certo punto al Club Alpino Polacco mi fecero notare che ne avevo scalati 12 ed era stupido non fare anche gli altri 2.
Così pensai, ok, come posso fare, dovrei fare due 8.000 in una stagione. Allora invitai Bianchi e Kuntner al K2, puntando al versante nord, quello cinese, ma andando presto, in giugno. Questo per poter raggiungere la spedizione Polacca che in luglio sarebbe stata al Nanga Parbat e avrebbe allestito la parete.
Al K2 per la prima volta avevo un telefono satellitare, di una società italiana, grande come una valigia. Chiamai il presidente del mio Club Alpino per confermare la vetta del K2 e chiedere informazioni sulla spedizione al Nanga Parbat ma mi disse che non avevano raggiunto la vetta a causa del mal tempo, ed erano ritornati a casa. Tutte le spedizioni del 1996 avevano abbandonato il Nanga Parbat e io per timore cercavo una scusa per andarmene io stesso, ma era sempre bel tempo, un giorno dopo l’altro, così ad un certo punto mi decisi, sebbene non sapessi nemmeno che direzione prendere.
Ebbi paura quella volta, ero completamente da solo, come avrei potuto testimoniare che ero stato in vetta? Cercai qualcosa su quella cima che potesse testimoniarlo ma c’erano solo pietre, pietre comuni.
Però fui fortunato, trovai un chiodi di bronzo, con un’incisione: Austria 1976.
Fu così che completai la mia Corona dell’Himalaya ma ritendo che ci siano sfide più interessanti per gli alpinisti rispetto a questo record.
Hans Kammerlander
Sei stato un grande alpinista ma anche un grandissimo sciatore di ripido, come nacque questa questa passione?
Sono nato in Valle Aurina – Alto Adige, in una piccola malga senza corrente e con i miei fratelli da bambini lavoravamo. Nel poco tempo a disposizione mi divertivo a fare qualche discesa, con delle specie di sci che mio padre a aveva realizzato in legno. Così nacque questa grande passione.
Se penso alla mia vita posso dire di aver lavorato davvero tanto, ma quando non ho lavorato ho combinato dei grandi casini (ride, e con lui tutto il pubblico n.d.r.).
Così ad esempio quando avevo 8 anni un giorno stavo andando a scuola. Il tempo era bellissimo e così pensai di cambiare programma, andai a fare la mia prima cima, una cima da più di 3.000 m sopra il villaggio. Iniziai quel giorno a scalare.

Il tuo Everest Hans. Lo scalasti da Nord, in 16,45 ore (record imbattuto) e una volta in cima scendesti con gli sci. Ce lo racconti?
Da giovane non avevo la possibilità di fare spedizioni in Himalaya, facevo il muratore ma sapevo che non era ciò che volevo per la mia vita. Cominciai ad allenarmi e a vent’anni diedi l’esame come Guida Alpina. Iniziai a lavorare per la scuola di Alpinismo di Reinhold Messner e ad un certo punto lui mi propose di fare un 8.000 assieme.
Non avevo esperienza in alta quota, ero stato al massimo sul Monte Bianco, ma pensai che la grande esperienza di Reinhold mi avrebbe aiutato. Fu così che scalammo per il Cho Oyu, in inverno, nel 1983. Non arrivammo in cima, faceva troppo freddo e c’era troppo vento.
Quando sento le storie di Krzysztof o Simone, le loro scalate in inverno, non posso che provare grande ammirazione, in quelle condizioni è davvero impossibile. E spesso anche in primavera.
In quattro anni con Messner concatenammo il Gashermum I e II (Prima concatenazione di un 8.000), scalammo il Dahulagiri e l’Annapurna, il Makalu e il Lothse.
Ci parli di quel concatenamento?
Fu un’esperienza durissima. Eravamo da soli, senza sherpa, per otto giorni, spesso nella bufera. Messner era quello dei due che aveva una grande esperienza ma fu mia l’intuizione di partire dal Gasherbrum II.
Era bellissimo scalare in quegli anni in Himalaya, eravamo quasi sempre soli, qualcosa che oggi non si vive più.
Dopo il Lothse e sette 8.000 condivisi, nel 1986 (che per Messner era il 14° ottomila) le nostre strade si divisero.
Per me fu molto complicato perché fino ad allora lui si era occupato di tutto dal punto di vista organizzativo, anche di raccogliere la maggior parte dei fondi necessari alle spedizioni.
Fu allora che cambiai la mia idea di alpinismo che da quel momento sarebbe stato combinato a discese con gli sci.
Everest e Nanga Parbat, li sciasti entrambi una volta arrivato in cima, cosa puoi dirci in proposito?
Sciai l’Everest nel 1996 ma sei anni prima feci il Nanga Parbat, con Diego Wellig. Il Naga Parbat per me rappresentò il limite, era meno alto ma ancora più ripido dell’Everest e una caduta avrebbe significato “non avere mai più il mal di denti” (risate del pubblico n.d.r.).
Fu lì che la discesa stava fin da subito finendo in tragedia, giusto?
Si, già 50 m sotto la cima con gli sci staccai un’immensa slavina che rotolò giù per il canalone.
Come si sale l’Everest in un tempo record scendendolo poi con gli?
Mi allenavo tantissimo per i miei progetti, passavo gli inverno ad allenarmi in Dolomiti con gli sci e feci anche un trekking in Nepal, un mese a camminare fino a 5.000 m, per rafforzare la mia motivazione. Il Nepal è un luogo magico per questo.
Feci lo Shisha Pangma per acclimatarmi nel 1996 e poi direttamente l’Everest.
Perché facesti l’Everest in solitaria?
Fino a 7.000 m fui accompagnato da due amici italiani poi rimasi solo. Non volevo fare bivacchi né portarmi tutto il necessario per farli. Non mi portai niente, se non un litro di tè. Lo zaino pesava meno di 5 Kg, con gli sci.
Delle prime curve su quella montagna, cosa ricordi?
Fu uno dei momenti più intensi della mia vita. Quando sulla cima tolsi i ramponi e agganciai gli sci mi sentii così stanco. Esitai diverso tempo prima di partire poi fu tutto molto più facile. Impiegai sei ore a scendere, mi fermavo ogni 10 m. Non era propriamente sciare, più che altro scivolare. Ma era il mio sogno, e l’ho realizzato.
Simone Moro
Dopo Krzysztof e Hans è il tuo turno sul palco, cosa ci racconti?
Beh, al cospetto di due giganti di questo tipo io mi sento un nano. Wielick, Kammerlander, assieme a Messner ed Anatolij Bukreev sono stati per me una grandissima fonte di ispirazione, sono stati dei modelli e dei maestri.
Ho sempre considerato fondamentale avere dei modelli, qualcuno che ti aiuti a tracciare la tua strada, e una volta che lo hai fatto avere un maestro che ti aiuti a percorrerla. Kammerlander oggi ha detto che all’inizio della sua carriera è stato aiutato dalla grande esperienza di Reinhold Messner. Reinhold lo ha aiutato a diventare quello che è diventato, non la copia di qualcun altro. Wielick ha detto la stessa cosa, quando gli avete ricordato che ha scalato con Jerzy Kukuczka ha risposto che costui era un gigante dell’alpinismo.
Per me arrivare dopo generazioni di Cassin, di Bonatti, di Messner etc. è stato quindi di grande ispirazione, ma al tempo stesso questi grandi nomi avevano già firmato quasi tutte le grandi imprese. Dovevo trovare qualcosa di nuovo, una mia dimensione.
I Polacchi, provenienti da un paese senza grandi montagne (in termini di altezza) e sfavoriti da una situazione economica difficile mi ispirarono le scalate invernali. E lo stesso lo fece il fatto che Messner e Kammerlander non erano riusciti a scalare il Cho Oyu e il Makalu (in inverno).

Tu riuscisti a scalare il Makalu in inverno!
Si l’ho scalato e ad oggi, su quella montagna, è stata la spedizione più leggera della storia, perché eravamo solo io, Denis Urubko e un cuoco, (che rimase al campo base).
Come riusciste a scalare Il Makalu così rapidamente?
Avevo un compagno speciale: Denis Urubko. Oggi spesso le spedizioni vengono organizzate fra scalatori che nemmeno si sono mai visti e si conoscono al campo base, ma le grandi imprese sono state firmate da cordate in cui prima di tutto gli alpinisti erano amici fra di loro. Con Denis abbiamo fatto alpinismo assieme per dieci anni ed eravamo una cordata ideale.
Quando hai capito che Denis era il tuo compagno ideale di cordata?
Verso la fine degli anni ’90 il mio compagno di cordata era Anatolij Bukreev. Una persona meravigliosa e uno dei più forti alpinisti di sempre. Prima dell’Annapurna avevo parlato con Sergio Longoni e avevo promesso che glielo avrei presentato per farlo conoscere al pubblico italiano, ma da spedizione di quell’anno, il 1997, lui Dmitrij Sobolew non tornarono. Amavo Anatolij, come maestro e persona speciale e quando scomparve volli andare là da dove veniva. In Kazakistan.
Lì conobbi Denis Urubko e capii che era un compagno di cordata ideale. Lui dormiva per strada, sulle panchine. Conosceva la fame, la fatica e aveva il grande sogno di fare l’alpinista.
Facendo i cinque 7.000 dell’unione sovietica vidi che forza e che coraggio aveva. Denis per me era un po’ come Kammerlander per Messner, dove il motore aiuta l’esperienza per realizzare la macchina perfetta. Non è questione di essere migliori del compagno è questione di complementarità, completarsi a vicenda consente di raggiungere grandi obiettivi. Ogni grande alpinista ha bisogno di un grande compagno di cordata.
Qualche domanda aperta ai tre alpinisti
Cosa è rimasto da fare ai giovani, come è cambiato l’alpinismo?
Kammerlander – Per i giovani non è facile scegliere un obiettivo, noi avevamo un mondo da esplorare: prime salite, invernali, discese con gli sci, ma resta ancora tanto da fare e i giovani sono fortissimi.
Wielick – Credo che il grande alpinismo esplorativo non esista più. Nel senso che ora le grandi imprese sono alla portata solo di alpinisti professionisti. Noi eravamo degli amatori alla conquista della vetta, ora l’obiettivo è la difficoltà, è fare una parete, perseguire uno stile in particolare. La filosofia dell’alpinismo è cambiata.
Moro – L’alpinismo non è morto e ci sono giovani che stanno realizzando progetti meravigliosi, come Matteo della Bordella, Simon Gietl, Francois Cazzanelli o Simon Messner per citarne alcuni che mi vengono in mente al volo. Ci sono montagne da 6.000 o 7.000 m con vie inviolate e su cui realizzare grandissime imprese.
L’alpinismo non è morto nemmeno sugli 8.000, perché sebbene, come ha detto Hans, in certi periodi lì sia carnevale, basta cambiare stagione per vedere stravolte le regole del gioco, e nessuno è ancora riuscito a scalare la Corona in inverno o a scenderli con gli sci. Questi giovani alpinisti avranno anche il compito di comunicare in modo nuovo l’alpinismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, dovranno riuscire a fare appassionare e sognare il pubblico, come abbiamo fatto noi.