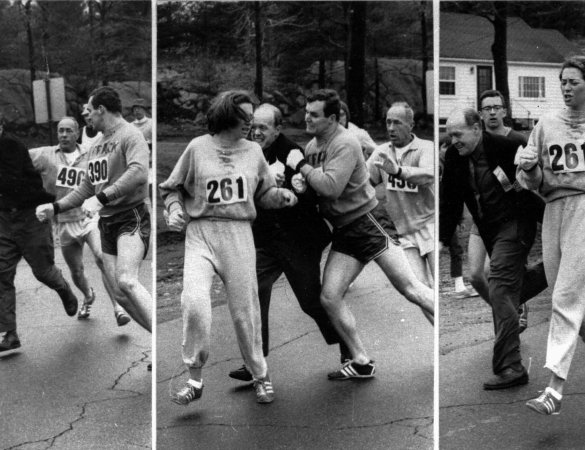Dopo una prestazione memorabile alla CCC – Courmayeur-Champex-Chamonix dell’UTMB Mont-Blanc, culminata con una vittoria in solitaria sotto l’arco di Chamonix, abbiamo avuto l’occasione di scambiare qualche parola con Francesco Puppi. Un atleta che ha saputo unire strategia, cuore e resistenza in una delle gare più iconiche del trail running mondiale. Ecco cosa ci ha raccontato.
foto courtesy HOKA e UTMB Mont-Blanc

Ma cosa ha fatto!!!
Ha tagliato il traguardo della CCC dell’UTMB Mont-Blanc da solo, tra due ali di folla, con il sorriso di chi ha appena scritto una pagina di storia. Francesco Puppi, classe ’92, è il primo italiano a vincere una delle gare più iconiche del trail running mondiale. Ma dietro al cronometro e al podio c’è molto di più: un pensatore della corsa, un comunicatore lucido, un atleta che ha fatto della consapevolezza il suo mantra. In questa intervista, Puppi si racconta tra fatica, filosofia e futuro, con la sincerità che lo contraddistingue.

DM – Se non sbaglio, hai definito la CCC come “una gara perfetta”. Cosa significa davvero “perfetta” per un atleta come te?
Francesco Puppi – Forse ti sbagli… Però diciamo che il giorno della CCC ho sentito davvero di aver messo in campo tutte le competenze e le abilità che avevo sviluppato e per cui mi ero preparato. Sono riuscito a far coincidere, nello stesso giorno, una serie di fattori sotto il mio controllo per produrre quella performance. Quindi, la perfezione non esiste, ma dal mio punto di vista quella gara è stata una delle più vicine all’idea di gara perfetta che ho in mente.
È sempre possibile fare meglio, avrei potuto correre anche più veloce. Ad esempio, nell’ultimo tratto in discesa, sapendo di avere un vantaggio consistente e un mondiale quattro settimane dopo, non dico che me la sono presa comoda, ma pioveva, non volevo rischiare. Dovevo solo arrivare al traguardo, quindi ho cercato di minimizzare il rischio, consapevole dei dieci minuti di vantaggio sugli inseguitori.
Perfetta, in questo senso, significa che sono molto contento della gara che ho messo in campo quel giorno. Forse più che perfetta, si può dire che ho prodotto un’eccellenza, in cui abilità, competenze e anche difetti, vulnerabilità e caratteristiche individuali hanno convergono per comporre quella performance.

DM – Hai gestito la gara con grande lucidità. Qual è stato il momento più critico e come lo hai superato?
Francesco Puppi – Credo che il momento più critico sia stato attorno al km 80, verso la stazione di Vallorcine. Ero molto stanco: all’ottantesimo chilometro di una gara da 100 ti sembra di essere quasi arrivato, ma mancano ancora 20 km, che non sono affatto pochi. Inoltre, gli ultimi 20 km della CCC — come anche dell’UTMB — sono particolarmente impegnativi e abbastanza tecnici. Da Vallorcine in poi ci sono tre salite, sei stanco e la mente ti gioca brutti scherzi. Non è facile stare in quelle situazioni di estremo disagio, sofferenza, dolore fisico, anche quando sei in testa alla gara, come lo ero io.
In quel momento mi sarei aspettato di sentirmi meglio, ma ho avuto un piccolo down. Fortunatamente c’era la mia crew a Vallorcine, che mi ha rifocillato e rincuorato. È stata una stazione molto rapida, meno di 20 secondi, ma è bastata. Poi, in cima all’ultima salita — quella della Flégère — pioveva di traverso, faceva freddo, c’era vento forte. È stato bello trovare il mio allenatore Tito e il mio amico Andrea, saliti con la funivia per assicurarsi che stessi bene e per farmi il tifo. Mi avevano notato un po’ sofferente a Vallorcine, ma lì mi ero ripreso. Gli ho fatto un sorriso: mi ha fatto davvero piacere vederli. Tra l’altro, sono dovuti scendere di corsa perché la funivia era chiusa, e si sono fatti la discesa sotto la pioggia, come me.

DM – Correre lungo tre nazioni, Italia, Svizzera e Francia, su un percorso così tecnico: come ti sei preparato mentalmente per affrontare questa sfida?
Francesco Puppi – In realtà il percorso non è particolarmente tecnico. Anzi, per essere una gara così lunga e varia, lo definirei abbastanza facile, soprattutto nei primi 50 chilometri. La parte italiana è impegnativa dal punto di vista altimetrico, ma i sentieri sono privi di tecnicità: molto veloci, super lisci. Per un atleta come me — non dico che non ami il tecnico, mi piace anche — ma mi trovo bene su percorsi corribili. Do sicuramente il meglio di me in contesti non troppo difficili tecnicamente, e quella parte mi ha fatto sentire molto a mio agio.
Mentalmente, secondo me, bisogna sempre portare rispetto alla distanza. Sono comunque 100 chilometri, e sapevo che sarebbe stata una gara da circa 10 ore. Non è poco. Sebbene l’UTMB sia il doppio come tempo, la CCC sembra la sorella minore, ma non lo è affatto. La prima cosa è fare economia di energie. Il mio mindset, quando affronto gare così lunghe, è cercare di ritardare il momento in cui sopraggiunge la fatica estrema. Il nostro sport è questo: sai che arriverà, ma cerchi di posticiparla il più possibile.
Nel frattempo, devi stare dentro la gara, perché vuoi vincere, vuoi essere competitivo. Cerchi di capire quali mosse degli avversari coprire e quali no, sfrutti i tuoi punti di forza e ti difendi dove sei più carente. Nel mio caso, in salita so di essere più forte, quindi posso forzare un po’ di più. In discesa, invece, so che devo tenermi e salvaguardarmi rispetto agli avversari.

DM – Nel tuo podcast parli spesso di “correre con consapevolezza”. Come si traduce questo concetto in una gara estrema come la CCC?
Francesco Puppi- Non si traduce tanto in relazione alla CCC nello specifico, ma ogni volta che un atleta va in gara ed è chiamato a esprimere il massimo della sua performance, avere consapevolezza dei propri mezzi — punti di forza e debolezza — è molto meglio che esserne inconsapevoli. Sai con maggiore precisione come gestire la gara.
Più riesci a essere consapevole, più riesci a raccogliere informazioni sulla gara, sul percorso, su come ti senti rispetto allo sforzo e alla sfida. In gara si prendono decisioni che non si prendono in situazioni normali, quando la mente è rilassata. Sei sotto sforzo, cambia tutto. Le decisioni possono essere grandi o piccole: seguire un avversario o no, mangiare o no, gestire il pacing, decidere la strategia.
Più hai consapevolezza delle tue caratteristiche, di ciò che sei in grado di fare e di ciò che non puoi fare, più riesci a gestire queste decisioni nel modo migliore possibile.

DM – Ti senti più atleta, scienziato o narratore della corsa?
Francesco Puppi – Senz’altro atleta. Scienziato… non so bene cosa significhi in relazione alla corsa. Sono un fisico, quello sì, ho una formazione scientifica, e questo probabilmente influenza il mio approccio alla corsa, alla vita e al pensiero critico.
Narratore forse lo sono un po’ di conseguenza. Mi piace raccontare quello che faccio. So che oggi è in qualche modo richiesto alla figura di un atleta professionista, e ho imparato a sfruttare diversi mezzi di comunicazione per raccontarmi, esprimere opinioni e punti di vista. Non solo su ciò che faccio, ma anche per cercare di creare cultura in un ambiente dove so che la mia voce può essere rilevante, interessante per alcune persone, ascoltata. A maggior ragione quando ho una credibilità data dai risultati e dal mio ruolo come atleta.

DM – Hai citato spesso il tuo allenatore Tito Tiberti. Che ruolo ha avuto nella tua evoluzione come atleta e come persona?
Francesco Puppi – Tito ha avuto senz’altro un ruolo di primo piano nella mia crescita, sia come persona che come atleta. Lo conosco da quasi 15 anni e collaboriamo da una quindicina d’anni: ha iniziato ad allenarmi nel 2014, quando ero ancora un atleta inesperto e abbastanza acerbo. Ero già un buon atleta, ma autodidatta, e avevo raggiunto la soglia della maglia azzurra senza un allenatore.
La decisione di collaborare con Tito è nata quando fui convocato al mio primo raduno con la Nazionale di Corsa in Montagna, nel 2014. Fino a quel momento ci ero arrivato con le mie competenze, ma capii che per fare un ulteriore step mi sarebbe servito l’aiuto di qualcuno. Mi rivolsi a lui.
Si cresce insieme
Secondo me ci siamo evoluti un po’ di pari passo: io come atleta, lui come allenatore. Non è molto più grande di me — è dell’81, quindi ha 11 anni più di me — e anche lui, come me, arriva dall’atletica leggera: mezzofondo, pista, strada. Abbiamo imparato insieme cosa significa allenarsi per il trail e per la corsa in montagna. Sono stato un po’ la sua cavia, se vogliamo: ha imparato ad allenare per il trail grazie a me e su di me. Direi che abbiamo avuto successo: qualcosa di buono l’abbiamo fatto.
Questo dimostra anche un’altra cosa: la teoria dell’allenamento dell’endurance è una sola. Si può declinare in modi diversi, ma alcuni principi rimangono validi, e noi siamo stati capaci di farli nostri e seguirli. Come persona, quando ho iniziato a lavorare con lui avevo 22 anni: ero molto giovane, uno studente universitario ancora acerbo come adulto. Grazie a lui, e a un confronto reciproco costante, sono cresciuto molto anche come essere umano.
Molti dei valori che ho non dico che li abbia presi da lui, ma sono stati temi su cui ci siamo confrontati, cercando di capirli insieme. Ha avuto un ruolo importante anche nel farmi acquisire fiducia in me stesso — cosa che ho sempre avuto poco — e nel processo, inteso come direzione e metodo di allenamento. Dopo 11 anni, direi che queste cose le facciamo abbastanza bene.
DM – La tua stagione è stata straordinaria: Canyons, Lavaredo, CCC. Come si costruisce una continuità di prestazioni a questi livelli?
Francesco Puppi – Si costruisce con tanto lavoro, tanto allenamento, tanta costanza e continuità nel tempo. Questa stagione non l’ho costruita l’anno scorso o nei mesi precedenti a queste gare, né due anni fa. L’ho costruita nell’arco di una carriera: ho iniziato ad allenarmi per questo sport più di 25 anni fa.
Forse è una delle cose che tante persone dimenticano. Vedono i risultati, che sono la punta di un iceberg fatto di continuità e di una quantità di lavoro che, se ci penso, è davvero impressionante. È così che si costruisce una continuità di risultati di questo tipo.
Carichi di lavoro modulati
Poi, secondo me, siamo stati bravi a modulare il carico di lavoro quest’anno, a focalizzare bene gli obiettivi, a impostare una stagione che avesse senso prima di tutto dal punto di vista tecnico, più che mediatico o legato ad altre dinamiche che in questo sport contano relativamente.
Ho avuto due momenti apice: Canyons e CCC. La CCC la metto insieme anche ai Mondiali di trail, che saranno tra una decina di giorni. Abbiamo costruito la stagione attorno a questi due appuntamenti. Le altre gare sono state un po’ accessorie: obiettivi in sé, ma anche tappe utili in prospettiva di quelli più grandi.
Quest’anno ci eravamo messi in testa di correre due gare da cento chilometri, per acquisire esperienza su una distanza più lunga rispetto a quelle che avevo frequentato fino all’anno scorso. Direi che l’esperimento ha funzionato: mi è piaciuto, i risultati sono stati ottimi. Ma ciò che conta di più è che ho imparato, sono cresciuto come atleta, e tutte queste esperienze mi hanno lasciato qualcosa di importante e significativo.
Sì, certi risultati sono importanti e magari sono quelli che la gente ricorda. Ma a livello personale contano di più i ricordi, le esperienze, le persone che mi hanno accompagnato in questi mesi e a queste gare. Grazie a loro sono riuscito a raccogliere questi risultati.
DM – Nella tua carriera c’è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto? Come hai ritrovato la motivazione?
Francesco Puppi – Direi che non c’è mai stato. Per me la motivazione non va cercata: fortunatamente è sempre stata lì. Non è tanto fare l’atleta professionista, gareggiare, ottenere risultati. Per me la motivazione è correre, allenarmi, migliorare, riuscire ogni anno a fare un piccolo step che mi renda un atleta e una persona migliore.
Anche se quest’anno non avessi avuto i risultati che ho avuto, ne sarebbe valsa la pena ugualmente. Allenarmi è forse la mia più grande fonte di gioia, benessere, felicità. Lo vivo come un grande privilegio: poterlo fare da professionista, per uno come me che ama profondamente questo sport, è il massimo.
Quindi tutta questa retorica del sacrificio… non è che la capisca tanto. Perlomeno su di me non si applica. Forse l’unico momento in cui non è che avessi perso motivazione, ma in cui tutto l’ambiente della corsa, delle gare, dell’atletica o del trail mi è sembrato lontano, è stato nel 2009-2010, quando sono stato negli Stati Uniti come exchange student per un anno di scuola superiore in un paesino dell’Indiana.
L’esperienza negli Stati Uniti
Lì l’esperienza sportiva c’è stata: ho partecipato a vari sport nella scuola, ho giocato a basket, fatto track, cross country, ecc. Però non è stata centrale. Forse per la prima e unica volta nella mia vita, i miei pensieri non ruotavano attorno allo sport. Era più una scusa per vedere altre persone, stare con gli amici, divertirmi.
In quell’anno l’ho vissuto con un’ottica diversa, che forse in Italia non ho mai più ritrovato. Anche quando sono tornato, all’università e dopo, l’allenamento, la corsa e lo sport sono sempre stati in cima alle mie priorità, anche quando correre non era un lavoro. Mi piaceva, e forse anche dal punto di vista sociale ero un po’ meno inserito. Non che fossi introverso, ma spesso preferivo allenarmi, andare alle gare, piuttosto che uscire la sera, andare a ballare.
Quindi no, non direi che ho mai perso la motivazione o pensato di mollare tutto. Anzi, proprio zero.
DM – Che rapporto hai con la solitudine in montagna? È un rifugio, una sfida o entrambe le cose?
Francesco Puppi – Credo che, per sua natura, lo sport di endurance ti porti a entrare in contatto profondo con te stesso e con la solitudine. In tanti allenamenti, in tante situazioni, sei da solo. La fatica ti mette a nudo, ti costringe a confrontarti con te stesso, con pensieri ed emozioni che non tutti conoscono — perlomeno chi non fa sport.
A me piace stare da solo. Non sono particolarmente socievole. Ho amici, certo, ma non sento il bisogno di cercarli in ogni momento. Ho una compagna, ma riusciamo a essere molto indipendenti. Mi piace allenarmi da solo, mi piace il silenzio della montagna, il contatto con la natura. Lo trovo un aspetto fondamentale del mio sport.
Quindi la solitudine la vedo più come un rifugio che una sfida. La sfida primaria è con me stesso, con le mie capacità. Ogni gara, ogni tentativo di esprimere la mia migliore performance è prima di tutto un confronto con me stesso, con il mio passato, con ciò che sono in grado di fare. Poi, a un secondo livello, è anche un confronto con gli avversari, nel contesto agonistico.
Rispetto alla natura, alla solitudine, alla montagna, sono dimensioni un po’ separate, non del tutto sovrapponibili. Non so se riesco a farmi capire. Sia l’agonismo e la competizione, sia l’introspezione e la solitudine sono aspetti del mio sport che mi piacciono molto. E forse sono due dei motivi principali per cui faccio quello che faccio.

DM – Che scarpe hai utilizzato per la gara, che sensazioni hai avuto?
FP – Ho utilizzato le Hoka Tecton X 3, lo stesso modello che ho indossato in tutte le gare di questa stagione, tranne a Sierre-Zinal, dove ho optato per le Rocket X Trail. Sono scarpe da competizione molto comode, reattive e confortevoli, ma allo stesso tempo performanti. Sono particolarmente morbide, ma anche molto reattive, grazie agli inserti in carbonio nell’intersuola.
Mi piace molto il feeling che offrono, la tenuta, il grip e soprattutto il comfort dopo tanti chilometri. Una delle cose peggiori in una gara lunga è il dolore alle gambe e ai piedi, che arriva dopo ore e migliaia di passi. Trovo queste scarpe particolarmente adatte a quel tipo di gare: leggere, performanti, ideali anche per un atleta piuttosto leggero come me, e molto veloci.
Le ho usate anche a Canyons, Lavaredo, Gran Canaria… insomma, sono state le mie compagne di viaggio per tutta la stagione.